di Carlo Duò e Alessandra Loru*.
Le parole sono gli strumenti peculiari della comunicazione umana e consentono di interagire con l’altro, descrivere il mondo, conoscere la realtà e concretizzarla. Il linguaggio è però anche il mezzo principale di espressione di pregiudizi, discriminazioni o stereotipi e, quando parliamo o scriviamo, l’uso che facciamo delle parole riflette e influenza il nostro modo di pensare e di agire.
Quotidianamente ci imbattiamo in esempi nei quali le parole sono utilizzate come mezzo per influenzare o indirizzare verso un determinato giudizio: basti pensare all’utilizzo che negli ultimi anni si fa di un termine come “clandestino”, volto a dare un connotato negativo alla notizia, stabilendo a priori che il soggetto si muova di nascosto, come una minaccia costante per la nostra sicurezza. Ma anche le espressioni quali “delitto passionale” o “omicida per troppo amore”, sembrano frutto della ricerca, più o meno consapevole, di giustificazioni, moventi e attenuanti quasi a volerci far entrare in empatia con il carnefice.

Il dire lavoratori “in esubero” e non “licenziati”, tariffe “ritoccate” e non “incrementate”, emolumenti “adeguati” e non “aumentati” sono tutti esempi quotidiani di una scelta attenta delle parole volte a indirizzare la nostra opinione verso una specifica direzione.
Secondo recenti ricerche, lo stesso uso della forma passiva o attiva nelle frasi ci può influenzare sull’elaborazione e sul significato che diamo all’evento. Davanti a un caso di femminicidio si usa spesso utilizzare la forma passiva “la donna è stata uccisa dal marito”, dove il soggetto è la vittima, ovvero la donna. E se ad essere ucciso è stato l’uomo? In questo caso, si predilige la forma attiva “la donna ha ucciso il marito”, dando nuovamente un ruolo di soggetto alla donna che ha compiuto l’azione. Questo uso della lingua italiana ci porta a mettere l’accento sempre sulla donna, prima come vittima e successivamente come colpevole, influenzando il nostro giudizio sull’evento e facendo intendere, in entrambi i casi, che la donna abbia comunque delle responsabilità. Questo processo non riguarda solo gli stereotipi di genere, ma anche quelli etnici, religiosi, territoriali, professionali e non ultimi quelli sulle caratteristiche fisiche e le disabilità.
Le parole utilizzate per comunicare, siano esse scritte su un giornale o pronunciate in un colloquio, ci forniscono molte informazioni implicite sulla “cultura linguistica” della fonte e attivano nel nostro cervello le stesse cellule che entrano in funzione quando siamo noi stessi a scriverle o pronunciarle. Queste cellule sono chiamate “neuroni specchio” e sono state studiate da un team di neuro-scienziati italiani, che ne hanno scoperto il funzionamento. I neuroni specchio si attivano anche quando esprimiamo una reazione emotiva positiva o negativa, grazie al processo imitativo che li caratterizza. In questo modo attiviamo negli altri la stessa risposta neuronale che avrebbero qualora fossero loro, in prima persona, a vivere quello stato d’animo. Provate a pensare al processo empatico implicato nel ricevere una bella notizia da un amico, o viceversa, fare una chiacchierata con una persona a voi cara che sta vivendo un momento difficile: inevitabilmente verrete coinvolti fino a rispecchiare le sue stesse emozioni. Questa sorprendente scoperta pone l’accento sulla responsabilità etica che singoli e mass media dovrebbero avere nell’utilizzo delle parole, al fine di acquisire una maggiore consapevolezza circa il loro ruolo nella reciprocità sociale.
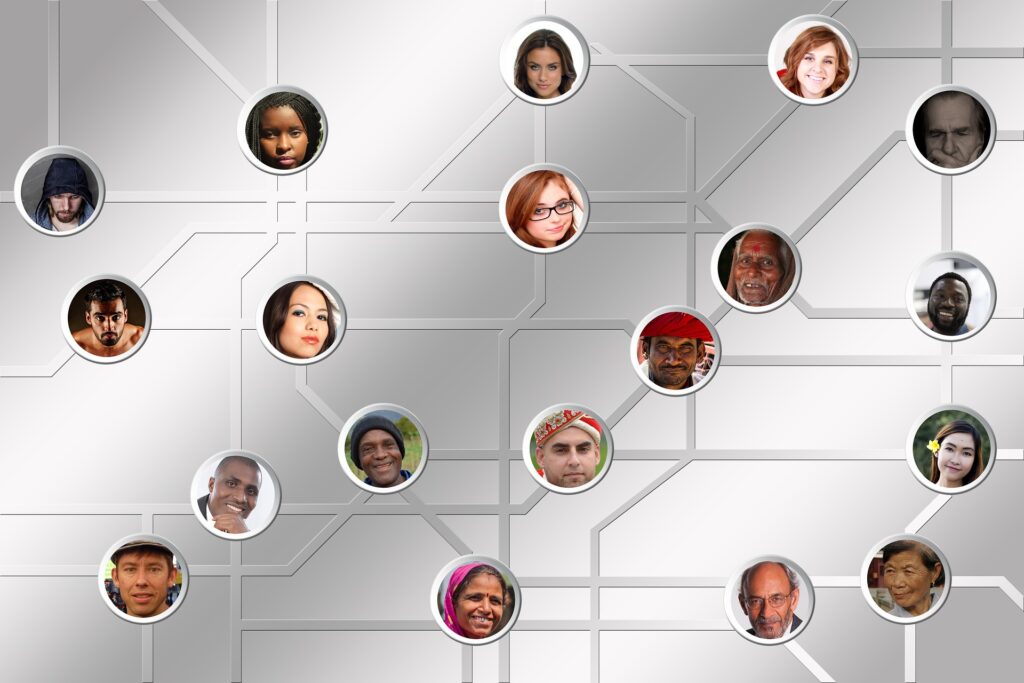
I pregiudizi e gli stereotipi, per quanto siano rivolti all’esterno, partono in primo luogo da noi, dal nostro stato d’animo e dalla percezione di noi stessi, così come evidenziato da recenti ricerche neuro-psicologiche. Le parole fortemente emotive mandano messaggi di attivazione al nostro paleo-encefalo e zittiscono parzialmente il centro di ragionamento logico, conducendoci in una sorte di “trance” che facilita l’interiorizzazione di pregiudizi, rafforzando la teoria per la quale la scelta dei termini possa concretamente cambiare la nostra visione del mondo. Milton Erickson, ipnoterapeuta di fama mondiale, utilizzava ad esempio la “ristrutturazione linguistica” per guarire i propri pazienti semplicemente agendo su un graduale e strategico cambio del loro modo di esprimersi.
L’utilizzo delle parole positive, infatti, stimola l’attività dei lobi frontali che includono dei centri specifici per il linguaggio. Più ci concentriamo sui termini positivi e maggiormente le funzioni nel nostro lobo parietale cominciano a cambiare, portando con sé anche un’evoluzione funzionale nella percezione di noi stessi e delle persone con le quali interagiamo. Una visione negativa di sé, invece, porta ad essere sospettosi, dubbiosi e pieni di pregiudizi verso l’altro: chi utilizza un linguaggio distruttivo e pregiudiziale, in realtà non fa altro che svelare tutta la sua negatività interiore.
Per quanto le nostre intenzioni e la nostra percezione del mondo vogliano essere più articolate possibili, c’è un aspetto che non è sotto il nostro controllo, ovvero la nostra lingua madre che influenza necessariamente il modo di approcciarsi alla realtà, al nuovo e all’ignoto. Un numero sempre maggiore di studi evidenzia come la nostra madre lingua abbia un forte impatto sul pensiero e sulla visione dell’esterno, ma anche sulle informazioni e sulla descrizione degli eventi utili per esprimere un concetto.
Per esempio, nelle popolazioni dove non esistono parole specifiche per definire le quantità, come nella lingua della tribù Piraha in Amazzonia, si utilizzano solo i termini generici “pochi” o “tanti” che gli impedisce di tener conto dei numeri precisi, limitando la capacità di concretizzare, organizzare e progettare. Anche nei popoli il cui linguaggio non possiede termini per indicare il futuro, ci sono forti difficoltà di programmazione e si riscontra una maggiore propensione all’accumulo fine a sé stesso, rispetto alle popolazioni la cui lingua distingue chiaramente una prospettiva temporale a lungo termine.
Tutti i pregiudizi e gli stereotipi si sono sviluppati e diffusi tramite le parole (che siano pensate attraverso il dialogo interiore, pronunciate o scritte) ed è con le parole che è possibile contrastarli, perché è il cambiamento del linguaggio rappresenta il passpartout perchè le cose intorno a noi esistano, si trasformino e siano come desideriamo. Il filosofo Antifonte di Ramnunte, nel IV secolo a.c., utilizzava il motto “Se cambia il linguaggio, cambia il pensiero”, anticipando quello che le neuro-scienze hanno confermato negli ultimi decenni:le parole hanno il grande potere sia di distruggere che di creare e, se utilizzate con consapevolezza sociale, possono diventare strumenti per cambiare il mondo.
*Psicologa dei Sistemi Sociali, è Specializzata in Psicologia dello Sviluppo, Perinatale e Scolastica. Si occupa da oltre 10 anni di progetti educativi, comunicativi, emozionali e di supporto genitoriale, familiare e infantile.

